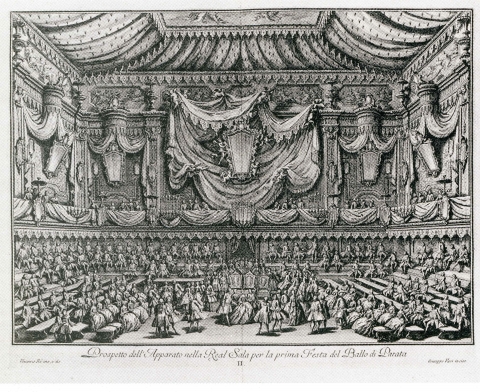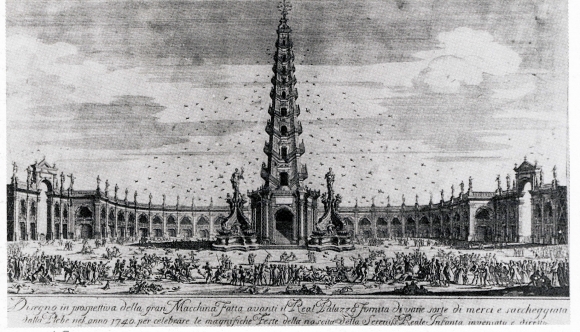“In nessun paese del mondo il popolo celebra le feste come in Napoli. L’ardore meridionale, la spensieratezza, l’obblio di ogni cura, il non esser solleciti della dimane come fu imposto agli Apostoli, l’abbandonarsi in somma alla gioia perché questa s’insinui nell’anima per tutti pori del corpo, è privilegio speciale del popolo napoletano. Né si manifesta meno il suo buon cuore nelle feste: se sta mangiando e bevendo all’aria aperta della strada in cui dimora o della taverna urbana o campestre, non passa amico a cui non offra un bicchier di vino e non lo costringa ad accettare, non pezzente a cui non dia almeno un pezzo di pane. Chi è presente a queste baldorie, a questi tripudii, se non è un freddo egoista, sente passarsi nell’animo quell’aperta e franca allegria; ed io ho raramente provato tanto piacere quanto nel vedere quella popolare contentezza nelle affollate bettole suburbane.
Giorno di tutto vigilia di nulla
Dolorosamente questo bel quadro ha il suo lato tristo. E qual cosa non l’ha quaggiù? Spesso si fan debiti e pegni per una momentanea gozzoviglia, verificandosi quel proverbio spagnuolo che dice «giorno di tutto vigilia di nulla». Spesso la vista di un ubriaco deturpa la scena finale dello spettacolo, e spesso la conturbano le risse, che riescono ad insanguinarla. Fra queste feste hanno il primato quelle di Pasqua. Poste nella stagione in cui si esce dal torpore dell’inverno (torpore relativo al clima che non è certo quello delle marmotte delle Alpi), in cui la primavera ringiovanisce l’anno, più che l’aspetto di famiglia delle feste del Natale, hanno l’aspetto di festa dell’intera città. Quelle cominciano e si compiono fra i domestici lari; queste se cominciano in casa, si vanno a compiere fuor del pomerio cittadino.
La settimana del digiuno
Preparativo alla crapula è il lungo digiuno dei di quadragesimali, Fatto più rigido in quelli della settimana maggiore. E la nostra plebe l’osserva bene quel digiuno, un po’ per divozione religiosa, un po’ per necessità. Il digiuno di quaresima del ricco sarebbe per un popolano lautezza squisita. Fagiuoli, minestra di cavoli, baccalà, aringhe, peperoni in aceto, zucche e carote alla scapece, cipolle, ed altri simili cibi, sono per lui nutrimento consueti. Sicché non è strano chela povera gente voglia in alcune occasioni festive dell’anno avere il suo banchetto, regalarsi del bendidio, farsi un tratto la sua buona scorpacciata, cavando il corpo di grinze. All’indigestione provvede il moto corporale e l’aria della campagna; e in ogni caso vi rimedia la consecutiva dieta abituale. L’ubbriachezza passa con un buon sonno. E se vi furono risse, quelle che non finiscono con una gita ai Pellegrini e con una villeggiatura gratuita alla Vicaria, hanno presto componimento in una pace procurata dagli amici o dai compari, pace più sincera e più durevole di quella onde ora godono le potenze europee. Detto questo così sui generali delle feste di Pasqua, entriamo a dire qualche cosa più in particolare.
Il prodromo si ha già nella settimana santa. Da ogni parte cominciano ad andare in giro per la città servi e facchini con regali, che non solo sono dimostrazione di affetto fra amici e fra parenti, ma il più sovente dimostrazione superba di superiorità a chi crediamo essere a noi interiori, e spesso turpe mercede di favori a persone in carica o ai loro facili ministri e servi. La gente elegante corre ai misereri per fare sfoggio di vestimenta, e trova una delizia la musica più noiosa del mondo. E mentre i pizzicagnoli incominciano l’apparato pasquale delle loro botteghe, il bel sesso corre a far mostra di sé nella passeggiata di Toledo, che dal tocco del giovedì rimane sgombro di carrozze fino alle dieci del mattino del sabato.
Le strade chiuse alle carrozze
Negli anni passati era vietato in questo tempo per tutta la città il passaggio delle carrozze e d’ogni altra sorta di veicoli. Di più, i bigliardi dovevano starsene inoperosi, e in molte case non si usava spazzare né sonare alcun istrumento. Qual ragionevolezza s’avesse questa usanza, io nol saprei dire: soltanto posso dire che ora rimane il divieto delle carrozze per Toledo e per qualche altra strada principale. E tutti vi si versano, come fiumi affluenti di un fiume reale, più che a visitare i sepolcri nelle chiese, a dare spettacolo di sé e de’ suoi abiti, a vedere i serpenti ringiovaniti che al cessare della fredda stagione escono dalle tane rivestiti di novella scaglia. Esposizione vivente, ove si vede e si è veduto. Si entra e si esce dalle chiese per ammirare il paramento, l’addobbo, la scenica montatura del così detto «sepolcro»; e per riposarsi dalla passeggiata siva a sedere alla predica della Passione.
La bottega del pizzicagnolo
Ed intanto il pizzicagnolo ha compito il suo apparato, dove salami e salumi, latticini e formaggi d’ogni maniera destano l’appetito nel comune dei riguardanti e le voglie nelle gravide. Per descrivere quest’altra esposizione ci vorrebbe un intero lessico culinario, con molte aggiunte per quelle specialità che non hanno riscontro nella bella lingua toscana. Vi dirò solo che anche qui. Il politico ha di che confortarsi, vedendo il prodotto dell’unità nazionale nell’unione degli svariati prodotti di tutte le italiane province. 1 prosciutti del Cilento dànno la mano ai zamponi di Modena e alle mortadelle di Bologna; il caciocavallo di Regno e di Sicilia fraternizza col parmigiano di Lodi e collo stracchino di Milano; il cacio di Cottone s’abbraccia a quello di Sardegna, e la ricotta salata di Avella dà un bacio alla ricotta fresca e al butiro di Roma. L’ordine e la simmetria che pone il pizzicagnolo fra le sue merci potrebbe servir di modello, non che ad un architetto, ma ad un amministratore. La gente attonita si ferma e guarda con occhi cupidi, mentre mentalmente riduce quei chilogrammi, quelle lire e soldi delle cartelle, in antichi pesi e monete di Napoli, e poi rivolge l’occhio del pensiero all’asciutto e magro borsellino.
E cresce il lavorio preparatorio: alle solite cantilene dei venditori s’aggiunge quella del grano per la pastiera, de’ limoni dolci, e su tutte domina il grido del beccaio ambulante: «chi ammazza o piecoro», grido a cui rimangono esterefatti molti e molti mariti. Le vie, le piazze, i mercati si popolano di venditori e di merci; le botteghe, e specialmente quelle dei pasticcieri e dei confettieri, si abbellano di straordinaria mostra delle loro mercanzie. E a questo universale movimento si mesce ad ogni pie’ sospinto una voce che intuona il «cento di questi giorni»; voce che scende dritto alla borsa per praticarvi un salasso.
La grande abbuffata
Ma ecco suona la gloria: spari festivi, campane, cannoni l’annunziano. Le carrozze riprendono il loro corso ordinario. L’ alleluja discaccia fin l’ultimo tristo segno di lutto, e tutti gli animi son volti al banchetto della dimane. Ma è ancor sabbato, poiché la Chiesa che anticipa di un giorno la morte, anticipata pur di un giorno la risurrezione. Quindi la plebe si divora devotamente l’ultima minga, l’ultima salacca, l’ultima sarda salata, mentre il ricco assapora delicatamente il consueto storione e fa penitenza col pesce spada, col merluzzo, colla sogliola, colle triglie, coi calamai. Gli apparecchi incalzano; gli spenditori sono in volta, e chi non l’ha fa la spesa da sé; fornai, macellai, pasticcieri, cuochi, ostieri, vinai, sono in grandissime faccende: fervet opus.
Non vi descriverò il pranzo pasquale: aprite la Cucina del duca di Buonvicino, e troverete più di quello ch’io potrei dirvi. Mai cibi di prammatica sono la minestra di Pasqua, lo spezzatello con uova e piselli, l’agnello al forno, l’insalata incappucciata, la soppressata colle uova sode, il tortano, il casatello, e per corona e suggello del pranzo la pastiera. Io vi parlo delle usanze del popolo, a cui più o meno si accosta la classe media. I ricchi e i nobili non si abbassano a queste vivande plebee, o se pure s’imbandiscono sulle loro mense, poco o nulla conservano del nazionale primitivo aspetto.
Ogni festa ricordevole ha fra noi il codazzo di altre due. Così al Natale, così alla Pasqua, così alla Pentecoste. Ed è ben ragione che non si passi di botto dalla gozzoviglia all’ordinaria forzosa frugalità. Il passaggio si fa per gradi, e l’esuberanza del dì della festa si vuol digerire nelle due feste secondarie. In queste si consumano gli avanzi del dì solenne, e si provvede a quel che manca nelle taverne, nelle osterie, nelle cantine, specialmente in quelle che sono nei deliziosi dintorni di Napoli. Pazzigno, il Granatello, il Pascone, Casanova, Lotrecco, Capodichino, l’Ottocalle, Miano, lo Scutillo, Antignano, il Vomero, Posillipo, Fuorigrotta, accolgono i popolani di Napoli. E senza uscire dalla città, guardate in uno di quei giorni il corso Vittorio Emanuele, la Marinella, Santa Lucia, Foria, Porto, il Pendino, le adiacenze di Porta Capuana e di Porta Nolana, e non avrete bisogno della testimonianza di Persigny per conchiudere che il popolo napolitano è il popolo più allegro e più contento del mondo.
Ma le feste, già declinanti nel martedi, sono finite nel dì seguente. Tutti ripigliano le loro occupazioni, meno coloro che non ne hanno alcuna. L’operaio torna al lavoro; e purché n’abbia, purché la sanità rida sul volto di lui e de’ suoi, manda al diavolo ogni malinconia, e pensa come fra cinquanta giorni possa andare a Montevergine o almeno alla Madonna dell’Arco.
(E. Rocco – Le feste di Pasqua -1857)