
Di Cecilia Gabrielli
«La città dei vivi» è un romanzo tessuto intorno a un terribile fatto di cronaca verificatosi a Roma nella primavera 2016: un ragazzo di 23 anni fu trovato morto nel quartiere Collatino dopo essere stato torturato per ore da due trentenni, “che però erano due persone normali”, che agiscono senza movente. I rei confessano, ma non riescono a dire perché e addirittura sembrano chiedere a chi inquisisce, come sia stato possibile e perché sia accaduto proprio a loro. La scenografia capace a tratti di farsi regia è Roma, la città che in quel momento non ha un sindaco, ma due papi.
«Ma mentre stavi nel panico hai creduto che tuo figlio fosse il ragazzo morto, o l’assassino?»
«Per quanto mi riguarda, rispose l’uomo, – poteva essere sia l’uno che l’altro. In questa città può succedere di tutto».
Questa è la successione dei fatti, il cui studio ha assorbito l’Autore in un lungo e meticoloso lavoro, che lo ha condotto in luoghi disparati a incontrare persone diverse e distanti. Ha raccontato lui stesso di aver collezionato documenti, cercato informazioni, raccolto dichiarazioni, interviste per mesi, giungendo a riempire due armadi di documenti, due armadi gemelli, contenenti sostanzialmente le stesse carte, ma archiviate secondo canoni diversi nell’uno e nell’altro. Uno è organizzato per personaggi, l’altro è una “dispensa” cronologica.
Aprendo le ante, nelle intercapedini tra i fogli e nei silenzi tra le parole, ha indagato i risvolti etici infiniti della riflessione sul male. Così Lagioia ha scritto e fra una riga e l’altra, andando a capo, ha riaperto paragrafi di questioni da affrontare e interrogativi con cui fare i conti, non solo per i responsabili immediati, per gli autori del crimine che fornisce l’occasio scribendi, ma per la società tutta e per ogni singolo lettore. L’Autore, infatti, si è messo in causa in prima persona e si è chiesto perché non sia accaduto a lui.
«Su di lui si infrange – perché sugli altri resta intatta – l’illusione che certe cose a noi non potranno mai accadere».
La domanda dolente si è ripercossa su centinaia di lettori, fremendo da un’anima all’altra, è diventata corale, facendo risuonare questioni etiche universali: esiste un confine ponendoci al di là del quale possiamo stare tranquilli ed essere certi che queste cose a noi non potranno mai accadere? Che cos’è il male? Che cosa lo provoca e come si concilia con il libero arbitrio, se si concilia? Da dove passa il male, dove cresce, perché s’insinua in certe vite, in quei momenti, in quei luoghi?
C’è la consapevolezza che il male non si può raccontare in astratto, non si lascia definire, come fanno l’amore e la libertà per esempio, che bisogna partire da un substrato, impelagarsi nel pabulum dei fatti come in laboratorio e indagare la tenuta di un’ipotesi, di un ragionamento. Così nasce la letteratura, che solleva dilemmi, si fa combustibile di riflessione e senza accorgersi produce la sublimazione degli atti nelle discussioni e alla fine, di nuovo, torna a depositarsi in terra e riconduce all’uomo anche l’inaccettabile. Un ritorno che non impone risposte ma educa all’accoglienza.
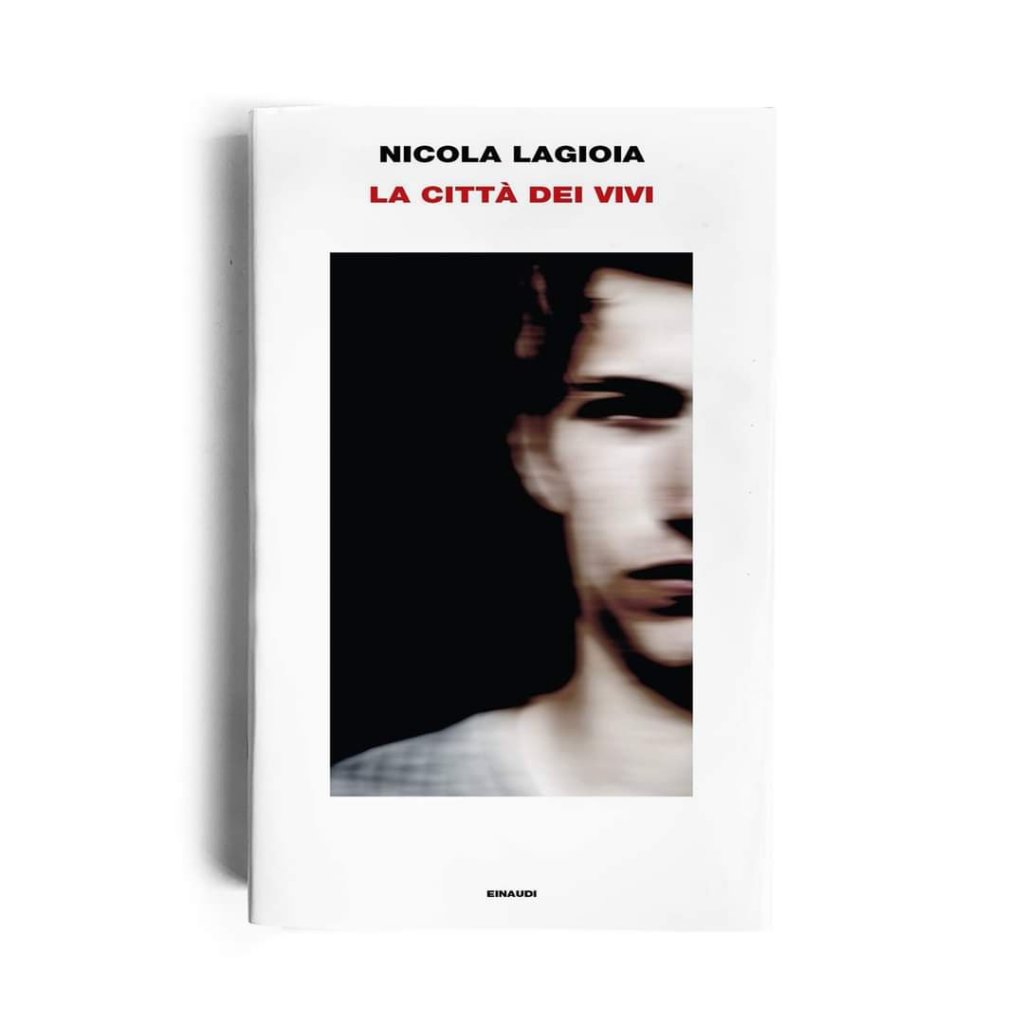
Insomma «Homo sum, humani nihil a me alienum puto». Sembra inevitabile citare Terenzio quando si ragiona del male, si può persino ribaltare lo specchio in «Satana sum…» come fece Dostoevskij, nel romanzo I Fratelli Karamazov (che pure abbiamo letto e condiviso). La letteratura ara il campo con le sue domande, i dubbi germogliano, intanto si delinea un percorso, che al Circolo della Lettura “Barbara Cosentino” di Roma è stato inaugurato, nel maggio 2016, intorno a La banalità del male di Hannah Arendt. Gli appassionati di letteratura classica trascorsero oltre due ore a dibattere e litigare sul “perché in Germania”, per cedere poi il passo sulla scelta e sul senso della parola “banalità”. L’anno seguente siamo saliti sulla Transiberiana letteraria (Delitto e castigo di Dostoevskij) e poi abbiamo attraversato “la modernità col passo della dirompenza”, soffermandoci sulle pagine di Truman Capote con A sangue freddo. Non sono mancati preziosi incontri con scrittori contemporanei come Edoardo Albinati e La scuola cattolic), Massimo Cacciapuoti e La notte dei ragazzi cattivi, Giuseppe Aloe con diversi romanzi, ma soprattutto con il seminario intorno a “Scrittura e grecità”.
Nicola Lagioia ci offre l’opportunità di proseguire questa riflessione e date le numerose richieste pervenute e l’interesse suscitato, l’incontro sarà trasmesso in diretta per tutti coloro che vorranno ascoltare e intervenire con i commenti, ai quali io stessa presterò la voce, per soddisfare domande, curiosità, raccogliere osservazioni e opinioni.
Sabato 20 febbraio alle 21.00 circa il Circolo della Lettura di Roma vi aspetta
in diretta sulla sua pagina Facebook con Nicola Lagioia
