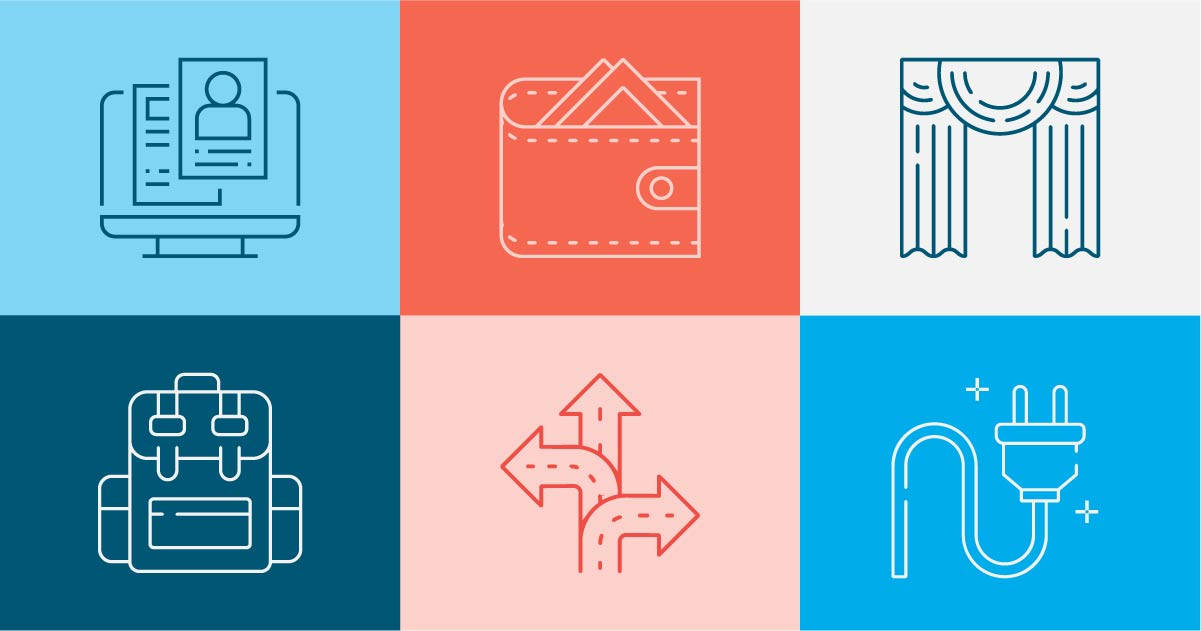Intervista di Eleonora Diquattro
La post verità, il post capitalismo, la post globalità, la post democrazia, la post modernità, il post ideologico e ancora tanti altri “post”, che negli anni abbiamo imparato a conoscere. Ma di uno, per certi versi, si sentiva la mancanza: “quello” della post economia. Nessuno finora, infatti, si era cimentato con un’espressione così suggestiva ma anche, evidentemente, impegnativa, difficile da “afferrare” viste le molteplici implicazioni sociali, politiche, civiche che ha il discorso economico.
A colmare questo vuoto ci ha pensato Francesco Maggio, economista e giornalista pugliese che vive a Milano, già ricercatore a Nomisma e a lungo collaboratore del Sole 24 Ore, da sempre attento nei suoi saggi ai rapporti tra etica, economia e società civile, che ha da poco dato alle stampe un nuovo libro intitolato, appunto, Post economia (Armando editore). Con un sottotitolo forse ancora più evocativo: l’utopia possibile di una società più giusta. Da qui prendiamo le mosse per questa conversazione con l’autore.
Perché questo richiamo all’utopia?
Nello scrivere questo libro mi sono fatto carico di un impegno gravoso che mi sento di definire, senza girarci troppo attorno, una vera e propria “rogna”, ossia provare a gettare le basi per un pensiero economico nuovo che metta al centro la persona con la sua umanità, i suoi bisogni e i suoi sogni, dopo che sono crollate le due più importanti impalcature concettuali del Novecento, da un lato il pensiero keynesiano, dall’altro quello neoliberista. Ma perché ciò sia possibile è necessario sfatare almeno i principali falsi miti che tuttora alimentano il discorso economico, sia in ambito profit che in ambito non profit. E va da sé che una simile operazione può assomigliare a qualcosa di temerario che può rasentare l’utopia. Ma, ci tengo a precisare subito, un’utopia possibile perché nel libro racconto tanti episodi in cui qualcosa che sembrava apparentemente irrealizzabile è poi diventato realtà.
A un certo punto lei cita una frase di Papa Francesco tratta dall’esortazione evangelica Evangelii Gaudium: “Questa economia uccide”. Come spiega un’affermazione così forte?
Forte ma sicuramente veritiera. E, aggiungo, meno male che almeno Papa Francesco ha il coraggio di andare dritto al cuore delle questioni economiche. Un’economia e una finanza che alimentano le disuguaglianze sociali, avvelenano l’ambiente, sfilacciano e mortificano i rapporti umani finiscono inevitabilmente con l’”uccidere” qualsiasi forma di convivenza. Bisogna avere il coraggio di dirlo. E anche di spiegare, come faccio ampiamente nel volume, quanto grandi siano le responsabilità del neoliberismo per questo sfacelo.
Il secondo capitolo è dedicato al terzo settore, argomento che appassiona entrambi da anni, e di cui lei è conoscitore e studioso. Perché lo definisce il “pianeta degli egosauri”? E perché afferma che “c’era una volta il non profit gioioso”?
Gli egosauri sono una figura immaginifica creata dal filosofo Pier Aldo Rovatti per indicare animali “mostruosi” con un corpo eccessivo, pesante, inutile, la cui mostruosità corrisponde a una sproporzionata superfetazione dell’io. Prendo a prestito questa immagine perché a mio avviso oggi nel Terzo settore ci sono “ai piani alti” troppi soggetti egoriferiti che hanno fatto dell’autoreferenzialità e dell’autocelebrazione la principale cifra identitaria. Finendo così con il penalizzare la stessa attrattività di un settore che per fortuna continua a essere “abitato” da milioni di persone straordinarie che, a titolo lavorativo o volontaristico, prestano la loro opera preziosa. Fino a non molto tempo fa non era così, il non profit era un settore gioioso, pieno di entusiasmo, voglia di sperimentare, di mettersi in discussione. Oggi, al contrario, riscontro soprattutto a certi livelli dirigenziali, molta burocrazia e purtroppo, non di rado, molta voglia di potere.
Cosa intende per “capitale narrativo”?
E’ un concetto strettamente collegato a quanto dicevo prima. Molte organizzazioni non profit sono nate grazie al carisma del fondatore, alla sua capacità di narrare un progetto che ha convinto tanti ad aderirvi, fattivamente o con donazioni. Ma questa narrazione va alimentata di continuo proprio come un lievito madre va periodicamente rinfrescato. Se invece lo slancio si esaurisce e rimane solo la figura ingombrante del fondatore che non fa crescere attorno a sé una nuova classe dirigente allora questo capitale narrativo prima o poi si esaurisce. E la stessa organizzazione finirà con il diventare irrilevante.
Nel libro lei dedica un intero capito al nostro Sud che, a suo dire, non ha scritto nel destino di dover competere sullo stesso piano di un Nord “efficiente e disincantato”, bensì può “reincantare di nuovo il mondo”. Che significa?
Oggi il Sud è sottoposto a molte pressioni da parte del Nord affinché intraprenda percorsi di sviluppo che però fanno solo comodo al Nord e mortificano le vocazioni imprenditoriali e comunitarie del Mezzogiorno condannandolo a un perenne inseguimento di quanto fanno le regioni settentrionali. Ho maturato l’idea che ciò accade perché forse davvero stavolta il Sud può diventare protagonista di un modello di sviluppo inedito e inclusivo. Ma ciò suscita malumori tra chi, al Nord, si è sempre sentito un primo della classe abituato a imporre i suoi diktat. Per questo riprendo una citazione del poeta Franco Arminio illuminante in tal senso: «Chi non sa nulla del Sud stia zitto, parli chi ha il coraggio di starci dentro, di attraversarlo lentamente. Il Sud ti avvilisce e ti esalta però è occasione di intensità. Se il Nord è efficiente e disincantato, quello che può fare il Sud e tornare a reincantarlo». Naturalmente poi spiego in dettaglio come cominciare, a mio avviso, a reincantarlo.
Lei nel libro si sofferma sulla famosa “Queen question”, ossia la domanda che ormai è ricordata nella letteratura economica come il colpo di grazia alla credibilità degli economisti che assestò la Regina Elisabetta II di Inghilterra, nel 2008, quando inaugurando un nuovo padiglione della London School of economics chiese al rettore, lasciandolo in un imbarazzante silenzio, perché i suoi docenti non avessero previsto la crisi. Quale sarà a suo avviso la “Queen question” da porre oggi agli stessi economisti?
Ne farei due. Avete imparato la lezione che senza contaminazione con altre discipline, preferibilmente umanistiche, ma ricorrendo solo a modelli teorico-matematici complicatissimi l’economia si allontana sempre di più dalla realtà, rivelandosi incapace di comprenderla? Avete maturato, finalmente, la consapevolezza che l’homo oeconomicus, il feticcio concettuale propagandato ad arte per indicare pulsioni esclusivamente egoistiche dell’essere umano, vada mandato in pensione e rimessa al centro del discorso economico la persona in carne e ossa? Temo tuttavia di conoscere già la risposta, ahimé doppiamente negativa.
Ha già cominciato a presentare il suo libro? Che riscontri ha avuto?
Il libro è uscito da appena un paio di mesi e in mezzo c’è stata l’estate. Ho già fatto un’interessante e molto seguita presentazione online con una libreria pugliese e sto cominciando a vagliare alcune date possibili per presentazioni in presenza in tutta Italia. Purtroppo il covid rende molto problematico definire date e luoghi con certezza.