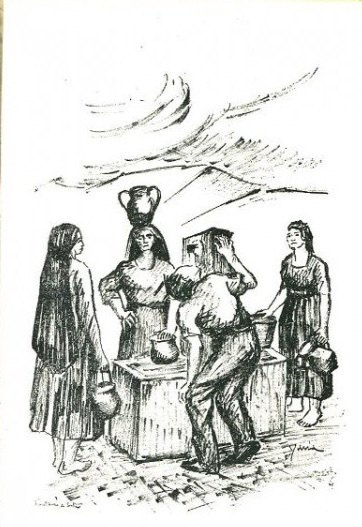di Giuseppe Antonio Martino
L’epiteto di “Movimento di massa” conferito al neorealismo e l’accusa di coltivare la “moda” dell’antifascismo facile e a tutti costi sembra estraneo ai narratori calabresi del secolo scorso (almeno ai più significativi), venuti su da una matrice contadina e da una realtà sociale che reclamava da molto tempo una voce letteraria. I contadini del Sud acquistano nel dopoguerra un posto rilevante nell’inventario dei temi del neorealismo (guerra, resistenza, dopoguerra, operai delle fabbriche, ecc.). Ma la figura dell’“intellettuale organico” alla classe operaia e contadina, cioè lo scrittore uscito dalle file del popolo e in grado di esprimere direttamente la volontà di lotta e di emancipazione non ha trovato molte incarnazioni nella letteratura italiana del dopoguerra.
L’esigenza di una letteratura nazionale e popolare, capace di colmare il vecchio e forte divario tra élites intellettuali e masse, fattasi impellente nella cultura italiana dell’immediato dopoguerra, è rimasta nella maggior parte dei casa insoddisfatta. Il concetto gramsciano di intellettuale organico si è potuto addirittura applicare a scrittori provenienti da classi sociali tradizionalmente detentrici del potere; quelli di esplicita estrazione ad ispirazione sociale sono stati tacciati spesso di contenutismo, di insufficiente finezza normale, di intellettualismo e prosaicità. Spetta invece a questi narratori, meridionali, e popolari per natura e non per moda, il merito di aver sottratto il tema del Sud all’equivoco mistificante dell’arcadia, del colore, del mito (a cui Corrado Alvaro aveva involontariamente contribuito) per scoprire la vere essenza del problema.
Troviamo pertanto scrittori che non sono solo narratori, ma anche (talvolta soprattutto) giornalisti e saggisti. Anche in Calabria troviamo reportage, inchieste, dossier che come le analoghe esperienze di Danilo Dolci in Sicilia e Rocco Scotellaro in Lucania, non sempre hanno pretese letterarie fine a se stesse, ma sono direttamente funzionali alla denuncia e alla protesta. Un elemento che salda i meridionali al tronco neorealista è il sostrato marxista, assunto e sviluppato dai calabresi con particolare impegno (solo qualcuno si sofferma in un generico escatologismo socialista). Sul piano dei valori stilistici e linguistici i narratori calabresi sono caratterizzati da alcune scelte di fondo, che li contraddistinguono nel filone “meridionalista” del neorealismo novecentesco. Superato il cliché dello scrittore calligrafo e disimpegnato, che si baloccava con le parole, per una scelta di contenuti e di esplicito impegno sociale, il neorealismo si è evoluto negli anni sessanta e settanta verso uno sperimentalismo formale, l’assunzione dell’imprecazione dialettale a veicolo di protesta, il recupero delle “sub-culture” come alternativa alla cultura borghese. Gli studi antropologici e folklorici (in Calabria l’opera di Luigi M. Lombardi Satriani) si evolvevano verso l’impegno, proponendo il folk come “cultura alternativa”.
I Calabresi hanno sì assimilato la lezione gramsciana dell’intellettuale organico e partecipato alle polemiche postbelliche del neorealismo, ma sono rimasti ancorati alla tecnica del realismo tradizionale, funzionalizzando il racconto e lo stile alla realtà pratica, etico-politica e rifiutando gli esperimenti estetici. La frase di Perri, Seminara, è impeccabile, logica, composta. Quella di Strati è secca, nervosa, breve, semplice, come l’impianto narrativo (solo Strati indulge, e con parsimonia, all’imprecazione e alla parolaccia).
Rèpaci, con la sua prosa estetizzante e colta entra nel novero dei neorealisti solo in parte e solo per i contenuti, per l’impegno socialista esplicito, per l’uso della cronaca come visione immediata dell’oggetto (V. Calabria grande e amara, Milano, Nuova Accademia, 1964), ma se ne allontana per le scelte stilistiche (una specie di neo-dannunzianesimo impregnato di mitologia, di classicismo attraverso cui veicola un discorso marxista assieme al suo spiccato individualismo). Rischia di ingolfarsi nel regionalismo di maniera.
Anche nell’opera di Corrado Alvaro è presente la tematica meridionalista, ma lo scrittore di San Luca alla conoscenza della vita regionale unisce quella della vita europea, maturata nell’intensa attività giornalistica come inviato speciale. È presente in Alvaro la frattura tra regione e nazione, tra vita pastorale e contadina e vita cittadina, il tema della fuga, l’amore odio verso il paese. Ma questi elementi affiorano nella narrativa alvariana circonfusi di un alone mitico e fantastico, come un’evocazione.
Altri scrittori, come Raul Maria De Angelis di Terranova di Sibari, Giuseppe Selvaggi di Cassano Jonio, Antonio Altomonte di Palmi, pur avendo affrontato il tema degli emarginati, dell’emigrazione, delle strutture agrarie in trasformazione, si sono distinti per il tentativo di saldare la cultura regionale a quella nazionale e in questa prospettiva si dissolve la tensione meridionalistica.
La situazione culturale e sociale sotto il fascismo ha prodotto il grido accorato di Giovanna Gulli, di Reggio, morta praticamente di fame a 23 anni. Il suo unico romanza Caterina Marasca Milano, Garzanti, 1944) insiste ossessivamente sul tema della fame.
In questo clima di emarginazione e sofferenza si levano in Calabria tra gli anni Cinquanta e Sessanta alcune voci di poeti fra cui Franco Costabile da Sambiase, morto suicida in giovane età, fratello spirituale di Scotellaro autore di La rosa nel bicchiere (Canesi, 1961 e ripubblicata di Qualecultura, Vibo valentia, nel 1994) e Lorenzo Calogero da Melicuccà, le cui opere pubblicate postume a Milano da Lerici (Opere poetiche vol. I 1962 e vol. II 1966), nella collana poeti europei, hanno dato avita ad un caso letterario prolungatosi per quasi un cinquantennio fino a porre il loro autore tra i maggiori poeti europei del 1900. È recentissima la pubblicazione di An Orchid Shining in the Hand, Chelsea, New York, 2015), un’antologia dei suoi versi tradotti in inglese da John Taylor.